Giovanna Cristina Vivinetto – Dolore Minimo

Giovanna Cristina Vivinetto per “DiVersi, solo le cose inutili sono poetiche” di Elisabetta Bucciarelli che oggi ci ricorda che siamo (anche) il nome che portiamo.
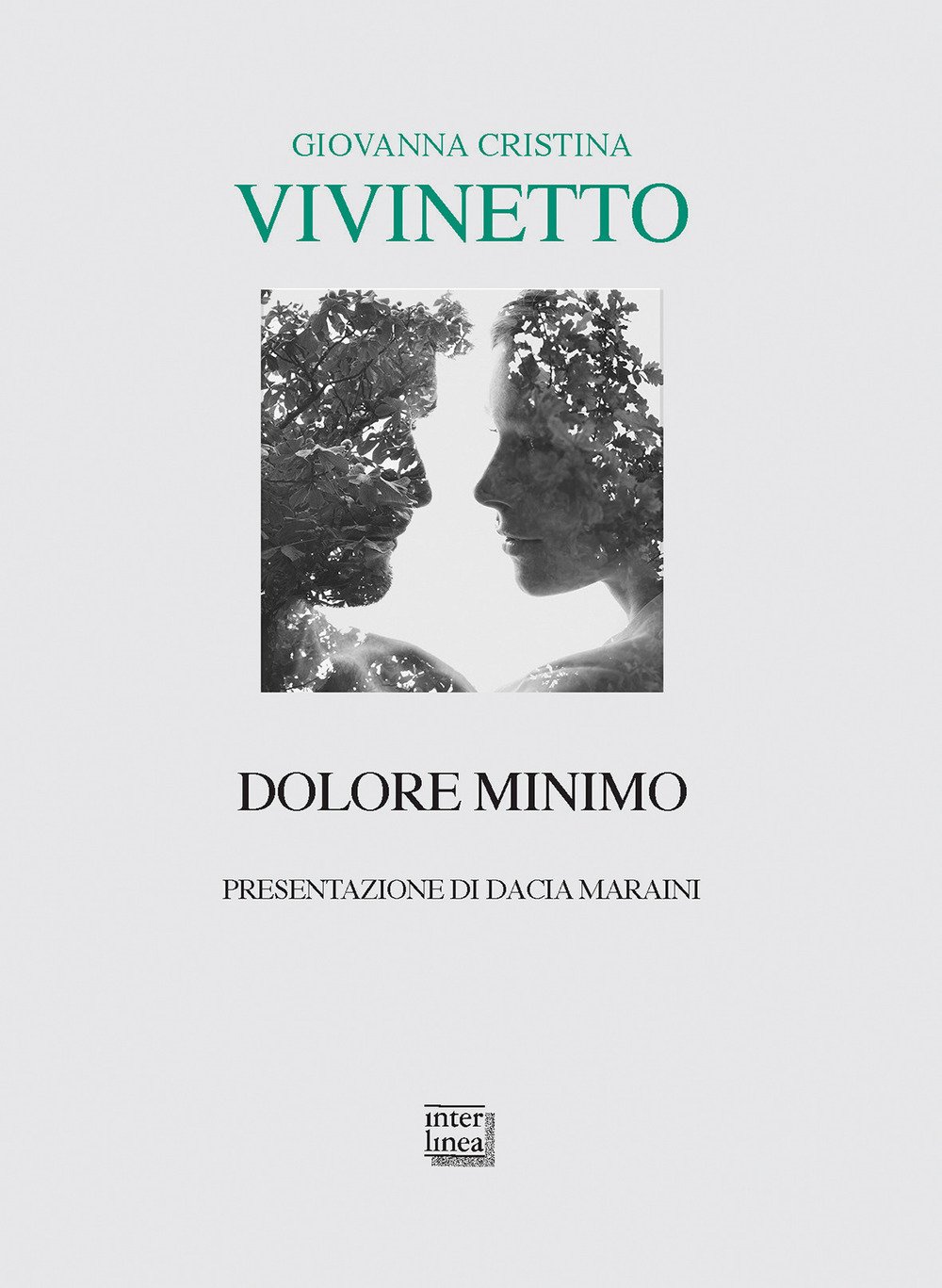
Casa editrice: Interlinea
Compra adesso
La verità è che i nomi ci scelgono
prima ancora di pronunciarli.
Sulle pareti, a ridosso delle strade,
nei vasi di garofani e ortensie,
sulle strisce d’acqua che rigano
le finestre al mattino, sulle
scarpe allacciate, sui pulsanti
dei campanelli, nelle stazioni
in disuso. Su tutto si coagula
un nome. Tutto ne risplende.E chi fugge dai nomi sappia
che non si sfugge alla nominazione
perché i nomi legano in nodi
di verità strette da calzare,
costringono in sillabe da pronunciare
a detti stretti. Da far male.I nomi che mi hanno scelta
non trovarono angoli da rischiarare.
Cessarono presto i significati
mentre ero intenta a scavare in ogni
lettera. Speravo nelle eccezioni,
in costrutti arcani da indagare
per darmi un senso.Ci rinunciai e con loro
all’arroganza della definizione.
All’insensatezza di attenersi
alle parole per vedere la realtà.La verità è che la realtà
dormiva a un palmo dal naso
sepolta da un cumulo muto
di nomi.
Questa poesia parla in due modi (anche di più). Il primo è relativo alla storia personale dell’autrice Giovanna Cristina Vivinetto e ci interessa molto, ma possiamo occuparcene ognuno per conto proprio, cercandone la biografia o meglio, comprando il libro e leggendo la prefazione di Dacia Maraini e la quarta (scritta tutta in stampatello), probabilmente dall’editore. Ma anche guardando il video linkato più avanti.
Il secondo modo di parlarci prescinde dalla storia che racconta, dall’intenzione del poeta e dai temi. E come accade con la poesia, ci riguarda.
Rileggendola un discreto numero di volte non sono riuscita a staccarmi dall’insistere sulla faccenda dei nomi. I nomi che ci chiamano e ci definiscono. L’elenco sarebbe lunghissimo ma quelli che m’interessano di più sono i nomi imposti alla nascita o che gli altri scelgono di utilizzare quando entrano in relazione con noi. Pensateci. Qualcuno decide di assegnarci un mucchietto di lettere, qualcun altro le separa e ne usa solo la metà. Altri ancora ci attaccano ipsilon finali, troncano o aumentano le consonanti, li sfibrano o li trasformano in arzigogoli simili ai nick sul web. Betta Betty Bet Bit. Oppure ne diminuiscono la portata o li vezzeggiano, Annina Annetta Annuccia. E ancora, li inglesizzano o spagnolizzano o tedeschizzano, Francisco, Francis, Franz. Potremmo andare avanti e invece passiamo a chi ci chiama con il cognome, una porzione del cognome, l’oggetto insito nel cognome. Senza chiedere il permesso, ci chiamano come vogliono, solo con quel suono, sempre lo stesso. Non è la voce della mamma e del papà, non è la nascita, non è la nostra scelta, è ancora altro. Un virus? E noi a volte ci ribelliamo (da piccoli ne soffriamo) a volte non rispondiamo e altre volte subiamo, accettiamo di essere chiamati così, cerchiamo una motivazione valida, nobile, simpatica, persino affettiva per cui alla fine sì, ma sì, va bene anche essere chiamati in quel modo lì. Che ci storpia, ci rende oggetto, ci priva del nostro personale intimo sentirci e per questo motivo ci sottrae il nostro preciso personale unico evidente suono. Questo ci dice molto su chi abbiamo di fronte. Sulla sensibilità e sulla capacità di associare una parola ovvero timbro colore suono a una creatura.
E allora chiediamo il permesso agli esseri umani. È Clo il tuo nome? Posso chiamarti così? Oppure preferisci di no? O preferisci il tuo nome intero, Claudia, o un altro diminutivo che ancora non conosco. O invece un maschile al posto del femminile, o viceversa? O altro ancora, un nome che non so ancora e che ti sei scelto tu, tutto intero.
Siamo anche il nome che portiamo, che rifiutiamo, che ci ricorda chi sentiamo di essere davvero. Siamo lettere e suono. Misuriamo la vicinanza e l’assenza anche attraverso l’uso dei nomi. Ricordiamo con i nomi. Amiamo sussurrando i nomi e stringiamo relazioni, vere o un po’ meno sincere, anche attraverso i nomi.
La prima parola con cui dobbiamo imparare a convivere è il “come mi chiamo” che in realtà è “come mi hanno chiamato” ma subito dopo c’è il “come mi chiami tu”. Da qualche parte però si nasconde la domanda (quasi) mai fatta: “qual è il m-io nome, come io mi chiamo per mia volontà?”. Quel suono è il nostro e non è detto sia sempre lo stesso per tutta la nostra vita.
Il suggerimento è una piccola ribellione, siamo pieni di angoli da rischiarare e per non rimanere sepolti in vita da un cumulo muto di nomi che non ci appartengono, proviamo a giocare come fanno gli adolescenti, i writer, i rapper, gli artisti; proviamo a chiedere di non chiamarci mai con un nome etichetta. Un nome di comodo, un nome pezzetto, parziale, ordinario.
La poesia, a volte, è scintilla di rivoluzione.
Ho acquistato Dolore Minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, Interlinea, su Amazon perché quando l’ho cercato nelle mie librerie di riferimento non c’era ancora. Ecco un video dove potete sentire la sua voce.
Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Dottoressa in Lettere moderne con una tesi in Critica letteraria e letterature comparate sul mito letterario di Fedra, vive attualmente a Roma, dove studia Filologia moderna presso l’Università “La Sapienza”. Suoi testi sono apparsi sul n°86 della rivista di poesia e critica letteraria “Atelier” (presentati da Giovanna Frene), sulla rivista “Pioggia Obliqua” (con una nota di lettura di Alessandro Fo) e sui siti web “Poetarum Silva”, “Atelier online”, “Pageambiente” e “Carteggi letterari”. Ha preso parte a diversi eventi letterari: lo scorso maggio è stata ospitata al Salone del Libro di Torino per un’intervista insieme a Franco Buffoni; a luglio è stata invitata al Festival “Parco Poesia” a leggere alcuni testi inediti; lo scorso 8 settembre ha preso parte all’evento “Di metro in metro” accompagnata dai poeti Stefano Carrai, Alessandro Fo e Stefano Pasi. La raccolta inedita “Dolore minimo” affronta il tema del transessualismo e della disforia di genere. La bio è tratta dal sito di Rainews.







